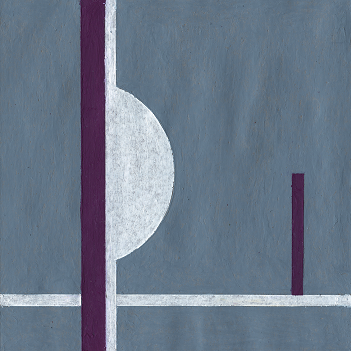 Le guerre siriane
Le guerre siriane
di Sergio Romano 
La guerra siriana ha compiuto nello scorso marzo il suo quinto anniversario. Il bilancio che, in mancanza di dati verificati da osservatori credibilmente neutrali, riflette gli interessi delle parti, è comunque disastroso. I morti sono probabilmente più di 300.000 (400.000 secondo alcune statistiche). Le persone costrette a lasciare la loro casa per cercare riparo in regioni del Paese meno travagliate sarebbero 3 milioni. Quelle costrette a lasciare la Siria per cercare rifugio altrove sarebbero: quasi 2 milioni e mezzo in Turchia; un milione e 200.000 in Libano; 630.000 in Giordania; 225.000 in Iraq e 137.000 in Egitto. Dei 18 milioni che formavano la popolazione siriana, prima dell’inizio del conflitto, gli esuli sarebbero quasi 5 milioni. Il numero dei prigionieri nei due campi non è calcolabile. Le relazioni commerciali con l’estero sono pressoché inesistenti. L’83% della rete elettrica sarebbe stata distrutta.
Non sarebbe giusto accusare l’Onu di essere rimasta inoperosa. Pochi mesi dopo le prime grandi manifestazioni degli oppositori del regime, il Segretario generale dell’organizzazione internazionale ha inviato in Siria un suo predecessore, Kofi Annan. Il mediatore ha prodotto, nel marzo del 2012, un ragionevole piano per la sospensione delle ostilità che prevedeva l’apertura di corridoi umanitari e misure di assistenza per la popolazione. Ma il progetto è rimasto lettera morta, i combattimenti a Homs e Aleppo sono diventati sempre più feroci, Kofi Annan si è dimesso e il suo posto è stato preso da Lakhdar Brahimi, diplomatico di grande esperienza, già ministro degli Esteri dell’Algeria fra il 1991 e il 1992, quando anche il suo Paese era teatro di una sanguinosa guerra civile. Ma i suoi sforzi sono stati inutili e le sue dimissioni nel luglio 2014 hanno prodotto un terzo mediatore nella persona di Staffan de Mistura, già sottosegretario agli Esteri nel governo Monti del 2011. Egli non è riuscito a interrompere la battaglia di Aleppo e il suo ruolo è stato limitato, nel frattempo, da un nuovo negoziato voluto dalla Russia che ha prodotto i due incontri di Astana, in Kazakistan, del gennaio e del marzo del 2017. È parso per qualche giorno che gli Stati Uniti rinunciassero a pretendere l’«abdicazione» di Bashar Al Assad, ma un attacco chimico contro Khan Shaykun (una città nella provincia di Idlib controllata dai fondamentalisti di Al Nusra) ha comportato il brusco cambiamento della linea politica del nuovo presidente americano. Il 7 aprile le navi statunitensi nel Mediterraneo hanno lanciato 59 missili contro la base di Shayrat da cui sarebbero decollati gli aerei siriani che avevano colpito Khan Shaykun. Damasco nega qualsiasi responsabilità, Mosca lo sostiene, Washington ribadisce l’accusa e la Commissione dell’Onu sulla Siria ha preferito attendere, prima di esprimersi sull’uso del sarin, il giudizio degli esperti.
Ciascuno di questi episodi dimostra che nessuno dei combattenti è disposto, per il momento, ad accettare patteggiamenti. Tutti sono convinti di poter vincere o, più semplicemente, temono – come accade spesso ai soccombenti nelle guerre civili – di perdere tutto: i beni e la vita.
Il contrasto sarebbe meno aspro, tuttavia, se alla guerra fra i ribelli e il regime non se ne aggiungessero altre due. In primis quella religiosa.
La Siria è prevalentemente abitata da musulmani sunniti (il 74%), ma gli alauiti (una branca della grande famiglia sciita) rappresentano il 13% della popolazione e sono la patria tribale della famiglia regnante; mentre i cristiani, a cui il regime degli Assad ha sempre garantito sicurezza e rispetto, sono il 10% della popolazione. In un contesto politico e religioso in cui, soprattutto dopo l’invasione americana dell’Iraq, sunniti e sciiti si guardano in cagnesco, la Siria assomiglia all’Europa durante la guerra dei trent’anni: un campo di battaglia in cui il confine fra le passioni religiose e gli interessi terreni è pressoché invisibile. Gli alauiti possono contare sull’aiuto degli sciiti iracheni, degli Hezbollah libanesi e dei guardiani iraniani della rivoluzione; mentre i sunniti sono sostenuti dai generosi finanziamenti degli Stati del Golfo e, in particolare, da quelli dell’Arabia Saudita.
La situazione è ulteriormente aggravata da altre circostanze. L’invasione americana dell’Afghanistan e dell’Iraq ha favorito la crescita di un nazionalismo iracheno che è diventato, a sua volta, terreno di coltura per il fanatismo islamista di Al Qaeda e per coloro che sognano la restaurazione del Califfato. I curdi sono presenti in tutta la regione: 18,3% della popolazione in Turchia, 17% in Iraq, 5% in Siria e 4% in Iran. Combattono con abilità e coraggio per contrastare le ambizioni nazional-religiose dello Stato islamico, ma anche per conquistare una patria in Siria che potrebbe allargarsi sino comprendere una parte dell’Iraq e, soprattutto, della Turchia. In altre parole, i curdi sono indispensabili per la guerra all’Isis ma, al tempo stesso, sono percepiti come potenziali nemici da alcuni paesi della regione. Il caso della Turchia è particolarmente interessante. Lo Stato di Erdogan è minacciato dagli islamisti dell’Isis – a cui deve alcuni dei più sanguinosi attentati da cui è stato colpito negli ultimi anni – ma ha sperato di trarre qualche vantaggio dalla rivolta sunnita contro il regime di Assad e teme i curdi più dei paladini del Califfato. Ne abbiamo avuto una prova nell’ottobre del 2014 quando la Turchia assisteva senza intervenire all’offensiva dell’Isis contro la città curda di Kobane. L’ambiguità della Turchia e i finanziamenti sunniti provenienti dai Paesi del Golfo hanno avuto l’effetto d’impedire la nascita di un’efficace coalizione contro l’Isis e di allungare così la durata del conflitto.
La terza guerra è quella che le maggiori potenze stanno combattendo sul corpo dolorante dello Stato siriano. Quando hanno preso posizione contro il regime di Bashar Al Assad e sostenuto la causa degli insorti, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia hanno fatto, su scala maggiore, gli stessi errori commessi contro il leader libico Gheddafi nel 2011. In primo luogo, hanno dimenticato che la Siria non era governata da un tiranno solitario e dalla sua corte di parenti e clienti. Era certamente un regime arbitrario, ma sostenuto da una minoranza religiosa (gli alauiti), dalla borghesia commerciale di Aleppo, dai cristiani, dalla macchina del partito Baath e da una larga parte delle Forze armate.
Pensare che questo Stato potesse cedere rapidamente ai ribelli è stato un imperdonabile errore di giudizio.
Hanno, quindi, ignorato la Russia, non tenendo conto delle due basi militari che il Paese aveva in Siria e della sua considerevole esperienza nella lotta contro l’islamismo radicale. Questi sbagli hanno avuto l’effetto di creare una situazione strategicamente assurda. Le democrazie occidentali vogliono sconfiggere gli islamisti, ma sono costrette a tollerare l’ambiguità dei paesi che li sostengono direttamente o indirettamente, da quelli del Golfo alla Turchia. Sanno che non possono combattere l’Isis senza l’aiuto di Damasco e di Mosca, ma continuano a trattare Bashar Al Assad e Putin come potenziali nemici.
Non è difficile comprendere perché una soluzione concordata e il ritorno alla pace siano in Siria così difficili.
