recensioni e segnalazioni 3/2014
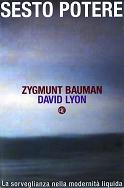 Zygmunt Bauman, David Lyon
Sesto potere
Zygmunt Bauman, David Lyon
Sesto potereLa sorveglianza nella moderna liquidità Laterza, 2013 pp. 159 - euro 16,00
di Akira
Sesto potere, può sembrare il titolo di un romanzo degno della migliore letteratura gialla o complottista. In realtà non è così. Il testo racchiude un intenso scambio epistolare/informatico tra due maestri del pensiero contemporaneo contenente sottili riflessioni e quesiti sulle varianti della connettività interumana a livello planetario.
Le categorie relazionali mutate, e in continuo mutamento, scontano l’assenza dei classici limiti territoriali – sostituiti dallo spazio digitale e da un’elevata messe di strumenti tecnologici – che annullano il de visu. Gli autori rilevano che la sociologia contemporanea «se la deve vedere col digitale». Il dialogo offre spunti, a tratti preoccupanti e a tratti liberatori, per delineare con attenzione civica e culturale la dimensione di questo fenomeno che, a buona ragione, è uno dei fattori dominanti della post modernità.
La conversazione a distanza tra Bauman e Lyon si svolge su un piano dialettico avvincente; viene analizzato l’impatto, a carattere esponenziale, della telematica sui rapporti interpersonali, sulle singole identità nonché sulle forme di inferenza da parte di enti dotati di potere pubblico e privato. Si tratta di poli decentrati – quali imprese di Big Data e gli stessi social network – in grado di cercare, valutare e, soprattutto, controllare i più piccoli dettagli che connotano la vita quotidiana di ciascun individuo per fare del commercio di dati il loro core business. La discussione approfondisce il tema della sorveglianza che, praticando il controllo sociale, ha modo di rilevare e archiviare dati per poi offrire, ‘liquidamente’, strategie differenziate: finanziarie, commerciali, ideologiche, di sicurezza. Si passa così dal modello tradizionale del panopticon a quello impalpabile del synopticon, dove il controllo esercitato da una pluralità di istituzioni politiche ed economiche è maggiormente decentrato e pervasivo. Si assiste, in altre parole, alla diffusione ‘controllata’ della sorveglianza, a sua volta coniugata con l’acquiescenza dei singoli che ben percepiscono, anzi forniscono essi stessi collaborazione volontaria, talvolta entusiastica, consentendo un potere penetrante e connettivo alle tecnologie (si pensi ai messaggi scambiati su Twitter o i «mi piace» su Facebook).
Il passaggio dalla società solida a quella liquida è irreversibile – secondo quanto detta-gliatamente esposto da Bauman e Lyon – come lo sono le pratiche della sorveglianza.
Gli autori, richiamando anche altri studiosi cimentatisi sul tema negli ultimi decenni, affrontano – con il piacere intimo del confronto e mai autoreferenziale – il tragitto decostruttivo della società che da ‘igida’ diviene progressivamente globalizzata e, quindi, ‘iquida’. In tale trasformazione anche la sorveglianza viene percepita come un elemento liquido delle relazioni sociali, in altre parole, la sorveglianza assume la connotazione di un dispositivo di potere, ossia – secondo la traduzione che l’Editore ha scelto – il ‘sesto potere’. Il quadro che ne deriva è quello di un contesto puntualmente ‘scansionato’ che, lacerato dalle certezze della vetusta solidità sociale a cui eravamo ancorati, non lascia spazio a facili e rassicuranti ristrutturazioni. Ed è proprio in questo contesto fluido, aperto, irrisolto che soggetti pubblici e privati si confrontano rappresentando istanze, doveri, diritti, aspirazioni senza che sia evidente un nesso armonico e condivisibile.
Il radicale mutamento dei modelli di comunicazione, monitoraggio, captazione, tracciamento, selezione, archiviazione ha trasformato il modo di essere e di ‘sentirsi’, rendendo capillari i centri di potere reale che incidono sulle relazioni interpersonali e, di conseguenza, anche sulle politiche delle organizzazioni umane. Si tratta di informazioni moltiplicate esponenzialmente che inferiscono, come giganteschi frattali, su decisioni e libertà fino a comporre un nuovo paradigma del vivere.
Lo scambio di pensiero tra i coautori affronta, con equilibrio e momenti di rara intensità filosofica, le ‘impalpabili vulnerazioni’ dei singoli individui immersi e determinati dal fenomeno della ‘liquidità’, facendo emergere una metamorfosi della propria invisibilità, del proprio anonimato e, conseguentemente, della propria autonomia.
Questa tendenza conduce a una volontaria erosione dei propri confini intimi finendo per identificarci sempre più nella ‘rete’ piuttosto che nella ‘comunità’ fisica.
Quando, nell’affascinante dialogo, si giunge all’epilogo della rassegna di riflessioni – sempre esaustive e mai assertive – sul destino delle dinamiche e del controllo sociali, appare salvifico il possibile recupero trascendente dell’etica, controcanto alle liquidità problematiche e, forse, ancora punto fermo per tutte le politiche chiamate a organizzare le relazioni tra gli uomini e a guidare le istituzioni.
Il volume, aprendo uno scenario poliedrico e multidisciplinare, esprime le ansie e le energie del pensiero sociale contemporaneo, solo apparentemente distaccato dalle abitudini del quotidiano. Offre, a chi opera in organizzazioni complesse chiamate a servire la comunità, la possibilità di arricchire responsabilmente la propria sensibilità in direzione dei diritti e dei valori altrui. In tal senso, le esigenze di sicurezza della comunità – non della ‘rete’ – nella quale ci identifichiamo, costituiranno la contropartita alla libertà di comunicazione e di azione. In un simile contesto, sarebbe auspicabile che le autorità deputate a sorvegliare e a trattare le informazioni pensassero di riscrivere il limen del proprio mandato.
Le categorie relazionali mutate, e in continuo mutamento, scontano l’assenza dei classici limiti territoriali – sostituiti dallo spazio digitale e da un’elevata messe di strumenti tecnologici – che annullano il de visu. Gli autori rilevano che la sociologia contemporanea «se la deve vedere col digitale». Il dialogo offre spunti, a tratti preoccupanti e a tratti liberatori, per delineare con attenzione civica e culturale la dimensione di questo fenomeno che, a buona ragione, è uno dei fattori dominanti della post modernità.
La conversazione a distanza tra Bauman e Lyon si svolge su un piano dialettico avvincente; viene analizzato l’impatto, a carattere esponenziale, della telematica sui rapporti interpersonali, sulle singole identità nonché sulle forme di inferenza da parte di enti dotati di potere pubblico e privato. Si tratta di poli decentrati – quali imprese di Big Data e gli stessi social network – in grado di cercare, valutare e, soprattutto, controllare i più piccoli dettagli che connotano la vita quotidiana di ciascun individuo per fare del commercio di dati il loro core business. La discussione approfondisce il tema della sorveglianza che, praticando il controllo sociale, ha modo di rilevare e archiviare dati per poi offrire, ‘liquidamente’, strategie differenziate: finanziarie, commerciali, ideologiche, di sicurezza. Si passa così dal modello tradizionale del panopticon a quello impalpabile del synopticon, dove il controllo esercitato da una pluralità di istituzioni politiche ed economiche è maggiormente decentrato e pervasivo. Si assiste, in altre parole, alla diffusione ‘controllata’ della sorveglianza, a sua volta coniugata con l’acquiescenza dei singoli che ben percepiscono, anzi forniscono essi stessi collaborazione volontaria, talvolta entusiastica, consentendo un potere penetrante e connettivo alle tecnologie (si pensi ai messaggi scambiati su Twitter o i «mi piace» su Facebook).
Il passaggio dalla società solida a quella liquida è irreversibile – secondo quanto detta-gliatamente esposto da Bauman e Lyon – come lo sono le pratiche della sorveglianza.
Gli autori, richiamando anche altri studiosi cimentatisi sul tema negli ultimi decenni, affrontano – con il piacere intimo del confronto e mai autoreferenziale – il tragitto decostruttivo della società che da ‘igida’ diviene progressivamente globalizzata e, quindi, ‘iquida’. In tale trasformazione anche la sorveglianza viene percepita come un elemento liquido delle relazioni sociali, in altre parole, la sorveglianza assume la connotazione di un dispositivo di potere, ossia – secondo la traduzione che l’Editore ha scelto – il ‘sesto potere’. Il quadro che ne deriva è quello di un contesto puntualmente ‘scansionato’ che, lacerato dalle certezze della vetusta solidità sociale a cui eravamo ancorati, non lascia spazio a facili e rassicuranti ristrutturazioni. Ed è proprio in questo contesto fluido, aperto, irrisolto che soggetti pubblici e privati si confrontano rappresentando istanze, doveri, diritti, aspirazioni senza che sia evidente un nesso armonico e condivisibile.
Il radicale mutamento dei modelli di comunicazione, monitoraggio, captazione, tracciamento, selezione, archiviazione ha trasformato il modo di essere e di ‘sentirsi’, rendendo capillari i centri di potere reale che incidono sulle relazioni interpersonali e, di conseguenza, anche sulle politiche delle organizzazioni umane. Si tratta di informazioni moltiplicate esponenzialmente che inferiscono, come giganteschi frattali, su decisioni e libertà fino a comporre un nuovo paradigma del vivere.
Lo scambio di pensiero tra i coautori affronta, con equilibrio e momenti di rara intensità filosofica, le ‘impalpabili vulnerazioni’ dei singoli individui immersi e determinati dal fenomeno della ‘liquidità’, facendo emergere una metamorfosi della propria invisibilità, del proprio anonimato e, conseguentemente, della propria autonomia.
Questa tendenza conduce a una volontaria erosione dei propri confini intimi finendo per identificarci sempre più nella ‘rete’ piuttosto che nella ‘comunità’ fisica.
Quando, nell’affascinante dialogo, si giunge all’epilogo della rassegna di riflessioni – sempre esaustive e mai assertive – sul destino delle dinamiche e del controllo sociali, appare salvifico il possibile recupero trascendente dell’etica, controcanto alle liquidità problematiche e, forse, ancora punto fermo per tutte le politiche chiamate a organizzare le relazioni tra gli uomini e a guidare le istituzioni.
Il volume, aprendo uno scenario poliedrico e multidisciplinare, esprime le ansie e le energie del pensiero sociale contemporaneo, solo apparentemente distaccato dalle abitudini del quotidiano. Offre, a chi opera in organizzazioni complesse chiamate a servire la comunità, la possibilità di arricchire responsabilmente la propria sensibilità in direzione dei diritti e dei valori altrui. In tal senso, le esigenze di sicurezza della comunità – non della ‘rete’ – nella quale ci identifichiamo, costituiranno la contropartita alla libertà di comunicazione e di azione. In un simile contesto, sarebbe auspicabile che le autorità deputate a sorvegliare e a trattare le informazioni pensassero di riscrivere il limen del proprio mandato.
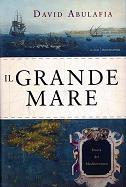 David Abulafia
Il grande mare
David Abulafia
Il grande mareStoria del Mediterraneo Mondadori, 2010 pp. 695 - euro 35,00
di Corito
Il volume di David Abulafia, docente presso l’Università di Cambridge, fin dalla sovraccopertina – dove figurano le riproduzioni di un quadro di C. Joseph Vernet (1714-1789) e di una mappa di Stefano Bonsignori (cartografo ducale di Francesco I, 1576-1586) – lascia intendere il pregio della ponderosa opera che percorre e ricostruisce la ‘storia umana’ del Mediterraneo lungo un percorso di 5.000 anni.
Il «grande mare» come un grande specchio della storia che, nella visione di Abulafia, si dipana in cinque epoche distinte: la prima, che partendo dai primi insediamenti umani di età paleolitica raggiunge il 1.000 a.C., vale a dire il periodo in cui si colloca il crollo di Troia VII a opera dei Greci; la seconda, che arriva sino al 500 d.C., in corrispondenza con la nascita dell’Impero Romano d’Oriente; la terza, che assiste a una lenta trasformazione verso un nuovo sistema sociale e si conclude con la grande crisi caratterizzata dalla peste nera (1347); la quarta, che vede delinearsi fasi alterne legate, dapprima alla marginalità del Mediterraneo rispetto alla concorrenza dell’Atlantico, poi al recupero della sua centralità, al momento dell’apertura del Canale di Suez (1869); la quinta che, dopo la perdita della dimensione lacustre, riconosce nel Mediterraneo un’area di transito verso l’Oceano Indiano e, nella seconda metà del XX secolo, le attribuisce una nuova identità, caratterizzata da un grande periodo migratorio. Se il Mediterraneo, in questo ampio spazio temporale, ha assistito allo sviluppo e al declino di civiltà e imperi, confronti e scontri tra religioni, scambi e fusioni di idee e culture si è visto, comunque e quotidianamente solcato da navi commerciali, flotte da guerra, pirati, crociati e migranti. Per l’autore, in ogni caso, simboleggia la superficie del mare stesso, «le sue coste, le sue isole, soprattutto le città portuali, che hanno rappresentato i principali punti di arrivo e di partenza per tutti coloro che l’hanno attraversato».
Nella sua continua mutevolezza, oggi il Mediterraneo è invece solcato da coloro che «se non sono già dei forestieri quando si mettono in mare, probabilmente lo diventeranno appena approderanno a qualche nuova costa», ed è tristemente connotato come un mare ‘sarcofago’ dove, troppo spesso, vanno a infrangersi le molte barche della disperazione.
Il «grande mare» come un grande specchio della storia che, nella visione di Abulafia, si dipana in cinque epoche distinte: la prima, che partendo dai primi insediamenti umani di età paleolitica raggiunge il 1.000 a.C., vale a dire il periodo in cui si colloca il crollo di Troia VII a opera dei Greci; la seconda, che arriva sino al 500 d.C., in corrispondenza con la nascita dell’Impero Romano d’Oriente; la terza, che assiste a una lenta trasformazione verso un nuovo sistema sociale e si conclude con la grande crisi caratterizzata dalla peste nera (1347); la quarta, che vede delinearsi fasi alterne legate, dapprima alla marginalità del Mediterraneo rispetto alla concorrenza dell’Atlantico, poi al recupero della sua centralità, al momento dell’apertura del Canale di Suez (1869); la quinta che, dopo la perdita della dimensione lacustre, riconosce nel Mediterraneo un’area di transito verso l’Oceano Indiano e, nella seconda metà del XX secolo, le attribuisce una nuova identità, caratterizzata da un grande periodo migratorio. Se il Mediterraneo, in questo ampio spazio temporale, ha assistito allo sviluppo e al declino di civiltà e imperi, confronti e scontri tra religioni, scambi e fusioni di idee e culture si è visto, comunque e quotidianamente solcato da navi commerciali, flotte da guerra, pirati, crociati e migranti. Per l’autore, in ogni caso, simboleggia la superficie del mare stesso, «le sue coste, le sue isole, soprattutto le città portuali, che hanno rappresentato i principali punti di arrivo e di partenza per tutti coloro che l’hanno attraversato».
Nella sua continua mutevolezza, oggi il Mediterraneo è invece solcato da coloro che «se non sono già dei forestieri quando si mettono in mare, probabilmente lo diventeranno appena approderanno a qualche nuova costa», ed è tristemente connotato come un mare ‘sarcofago’ dove, troppo spesso, vanno a infrangersi le molte barche della disperazione.
 Giuliano Da Fré
Storia delle battaglie sul mare
Giuliano Da Fré
Storia delle battaglie sul mareDa Salamina alle Falkand Odoya, 2014 pp. 472 - euro 24,00
di Corito
Il volume, dedicato alla storia della guerra sui mari, si sofferma su dieci battaglie ritenute decisive o, comunque, influenti per l’evoluzione dell’intera tematica e della stessa umanità.
Le prime cinque descritte dall’autore – Salamina (480 a.C.), Azio (31 a.C.), Lepanto (1571), Canale della Manica (1588), Trafalgar (1805) – hanno sortito effetti decisivi soprattutto sul piano storico. Da Frè si è soffermato sulla contestualizzazione degli eventi senza mancare di delineare l’apporto dello sviluppo tecnico e l’introduzione di novità tattiche, anche se oggettivamente carenti di riferimenti storici puntuali e rendicontazioni esaurienti.
La seconda parte del volume sottolinea come negli ultimi 150 anni l’avvento del concetto di ‘pensiero navale’ abbia modificato profondamente il ruolo del sea power, legato strettamente all’evoluzione che, nell’era industriale e di massa, assume l’idea di battaglia decisiva.
Le battaglie navali prescelte – Hampton Roads (1862), Yalu (1894), Jutland (1916), Midway (1942), Falkland (1982) – costituiscono riferimenti significativi della rivoluzione tecnologica che muta completamente l’approccio alla guerra navale, grazie anche all’ausilio fornito dalle numerose fonti disponibili.
Nel corso della storia legata al dominio del mare, la guerra navale ha conosciuto un lento sviluppo tecnologico: l’evoluzione che le navi subiscono, per passare dalla propulsione a remi a quella velica, richiede millenni e notevoli capacità tattiche e strategiche.
Se un ruolo significativo assumono le armi da fuoco sin dal XIV secolo, l’apertura delle grandi rotte oceaniche nella cosiddetta ‘età delle esplorazioni’ (a partire dal XV secolo) consente l’impiego di nuove navi a bordo alto – i galeoni – in grado di trasportare un maggior numero di uomini e di cannoni. Le linee delle navi nel tempo si affinano e, nel corso della Rivoluzione industriale, si assiste a un primo significativo ammodernamento delle artiglierie, mentre nella prima metà del XIX secolo la guerra navale beneficerà delle innovazioni apportate dalla nuova tecnica metallurgica e dalla propulsione meccanica fornita dal vapore. Nel XX secolo la radio consente di mantenere contatti tra le navi e i comandi a terra, mentre l’impiego di unità leggere siluranti e sommergibili cambiano ancora il volto della battaglia navale. Dopo il 1945 l’elettronica, la missilistica e l’energia nucleare entrano in competizione e, dagli anni Settanta fanno il loro ingresso portaerei e sottomarini spinti dall’atomo. Gli ammiragli del XXI secolo scorgono già armi laser e scenari da guerre stellari, missili balistici creati per affondare le superportaerei e sistemi in grado di bloccare nello spazio le minacce asimmetriche e non convenzionali degli ‘stati canaglia’. E pensare che, forse, tutto è cominciato con piroghe ricavate da tronchi e cortecce d’albero per disputarsi prodotti ittici di qualche laguna del Mediterraneo o del Golfo persico, all’alba della civiltà!
Le prime cinque descritte dall’autore – Salamina (480 a.C.), Azio (31 a.C.), Lepanto (1571), Canale della Manica (1588), Trafalgar (1805) – hanno sortito effetti decisivi soprattutto sul piano storico. Da Frè si è soffermato sulla contestualizzazione degli eventi senza mancare di delineare l’apporto dello sviluppo tecnico e l’introduzione di novità tattiche, anche se oggettivamente carenti di riferimenti storici puntuali e rendicontazioni esaurienti.
La seconda parte del volume sottolinea come negli ultimi 150 anni l’avvento del concetto di ‘pensiero navale’ abbia modificato profondamente il ruolo del sea power, legato strettamente all’evoluzione che, nell’era industriale e di massa, assume l’idea di battaglia decisiva.
Le battaglie navali prescelte – Hampton Roads (1862), Yalu (1894), Jutland (1916), Midway (1942), Falkland (1982) – costituiscono riferimenti significativi della rivoluzione tecnologica che muta completamente l’approccio alla guerra navale, grazie anche all’ausilio fornito dalle numerose fonti disponibili.
Nel corso della storia legata al dominio del mare, la guerra navale ha conosciuto un lento sviluppo tecnologico: l’evoluzione che le navi subiscono, per passare dalla propulsione a remi a quella velica, richiede millenni e notevoli capacità tattiche e strategiche.
Se un ruolo significativo assumono le armi da fuoco sin dal XIV secolo, l’apertura delle grandi rotte oceaniche nella cosiddetta ‘età delle esplorazioni’ (a partire dal XV secolo) consente l’impiego di nuove navi a bordo alto – i galeoni – in grado di trasportare un maggior numero di uomini e di cannoni. Le linee delle navi nel tempo si affinano e, nel corso della Rivoluzione industriale, si assiste a un primo significativo ammodernamento delle artiglierie, mentre nella prima metà del XIX secolo la guerra navale beneficerà delle innovazioni apportate dalla nuova tecnica metallurgica e dalla propulsione meccanica fornita dal vapore. Nel XX secolo la radio consente di mantenere contatti tra le navi e i comandi a terra, mentre l’impiego di unità leggere siluranti e sommergibili cambiano ancora il volto della battaglia navale. Dopo il 1945 l’elettronica, la missilistica e l’energia nucleare entrano in competizione e, dagli anni Settanta fanno il loro ingresso portaerei e sottomarini spinti dall’atomo. Gli ammiragli del XXI secolo scorgono già armi laser e scenari da guerre stellari, missili balistici creati per affondare le superportaerei e sistemi in grado di bloccare nello spazio le minacce asimmetriche e non convenzionali degli ‘stati canaglia’. E pensare che, forse, tutto è cominciato con piroghe ricavate da tronchi e cortecce d’albero per disputarsi prodotti ittici di qualche laguna del Mediterraneo o del Golfo persico, all’alba della civiltà!
 Antonio Mutti
Spionaggio
Antonio Mutti
Spionaggio
Il lato oscuro della società Il Mulino, 2012
«Passato prossimo» pp. 125 - euro 12,00
di Kyuzo
L’accattivante titolo del libro induce ad aspettative particolari, tutte rivolte a ottenere le tipiche emozioni che le trame ‘oscure’ di cui si ammanta la letteratura sui servizi segreti sanno offrire. Non è così. È un saggio intelligentemente articolato, compatto e fluido che non ricorre a banali riflessioni pregiudiziali ed estemporanee, ma affronta, con efficace sincretismo tematico, il delicato problema del moderno spionaggio e del suo impatto sulle architetture sociali. L’ottica primaria che guida l’esposizione è di un’analisi sistematica e coerente del ‘pragma’ adottato dalle istituzioni deputate a svolgere attività spionistica e a contrastare quella avversaria, raffrontato con i principi democratici e le regole sociali fondati sul rapporto di fiducia tra cittadini e organismi statuali. Un raffronto complicato, talvolta insidioso, che lascia emergere dilemmi e tensioni interpretative tra l’esigenza di segretezza, la necessità di condivisione delle informazioni e la cogenza di vincoli giuridici e deontologici.
Il volume si articola in tre capitoli. Il primo inquadra le linee di sviluppo teorico-storico dello spionaggio, definendone paradigmi, modalità e tecniche. Il secondo approfondisce forme e finalità dell’attività spionistica contemporanea, contestualizzando l’esposizione con riferimento a fallimenti e lacune di recenti esperienze che inducono a interessanti riflessioni in ambito socio-psicologico e politologico. È in questo segmento di testo che l’autore invita finemente ad apprezzare la difficoltà d’interpretare correttamente la produzione informativa da parte del decisore politico, a fronte di una crescente globalizzazione dei sistemi che regolano la convivenza. L’ultimo capitolo offre valutazioni e stimoli sulla dimensione più sensibile delle forme di spionaggio, quella che attiva più criticamente l’attenzione del lettore. Mutti si sofferma con sagacia sui tanti sospetti e timori che sorgono analizzando le difficoltà di bilanciamento tra sorveglianza dei cittadini per scopi di sicurezza nazionale e salvaguardia delle garanzie civili. Un equilibrio che implica intimamente il significato di democrazia. È questo il versante su cui pensiero filosofico e scienze sociali dibattono più aspramente, con sempre più matura sofisticatezza, quando sono chiamati a giudicare la pratica dello spionaggio nelle sue espressioni e finalità. Diviene imprescindibile il ricorso alle categorie della morale e dell’interesse, in un’alternanza disagevole di dubbi e certezze che fondano le loro ragioni sui meccanismi di potere. Il prezioso lavoro dell’autore contribuisce – tra i molti del settore, non sempre privi di ottuse preclusioni per l’operato del servizi – alla rivalutazione del ‘principio di affidamento’ nei confronti degli organismi d’intelligence. Un percorso tutt’altro che scontato ma indispensabile per ogni Paese evoluto.
Il volume si articola in tre capitoli. Il primo inquadra le linee di sviluppo teorico-storico dello spionaggio, definendone paradigmi, modalità e tecniche. Il secondo approfondisce forme e finalità dell’attività spionistica contemporanea, contestualizzando l’esposizione con riferimento a fallimenti e lacune di recenti esperienze che inducono a interessanti riflessioni in ambito socio-psicologico e politologico. È in questo segmento di testo che l’autore invita finemente ad apprezzare la difficoltà d’interpretare correttamente la produzione informativa da parte del decisore politico, a fronte di una crescente globalizzazione dei sistemi che regolano la convivenza. L’ultimo capitolo offre valutazioni e stimoli sulla dimensione più sensibile delle forme di spionaggio, quella che attiva più criticamente l’attenzione del lettore. Mutti si sofferma con sagacia sui tanti sospetti e timori che sorgono analizzando le difficoltà di bilanciamento tra sorveglianza dei cittadini per scopi di sicurezza nazionale e salvaguardia delle garanzie civili. Un equilibrio che implica intimamente il significato di democrazia. È questo il versante su cui pensiero filosofico e scienze sociali dibattono più aspramente, con sempre più matura sofisticatezza, quando sono chiamati a giudicare la pratica dello spionaggio nelle sue espressioni e finalità. Diviene imprescindibile il ricorso alle categorie della morale e dell’interesse, in un’alternanza disagevole di dubbi e certezze che fondano le loro ragioni sui meccanismi di potere. Il prezioso lavoro dell’autore contribuisce – tra i molti del settore, non sempre privi di ottuse preclusioni per l’operato del servizi – alla rivalutazione del ‘principio di affidamento’ nei confronti degli organismi d’intelligence. Un percorso tutt’altro che scontato ma indispensabile per ogni Paese evoluto.
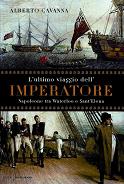 Alberto Cavanna
L’ultimo viaggio dell'Imperatore
Alberto Cavanna
L’ultimo viaggio dell'Imperatore
Napoleone tra Waterloo e Sant'Elena Mondadori, 2014 pp. 338 - euro 22,00
Napoleone, sconfitto a Waterloo, abdica per la seconda volta ed è esiliato a Sant’Elena, dove muore nel 1821. L’autore ricostruisce i quattro mesi più drammatici della vita dell’uomo. Ecco il ritorno a Parigi dopo la sconfitta del 18 giugno 1815; la partenza verso il golfo di Biscaglia; l’arrivo a Rochefort e la decisione di presentarsi al capitano dell’HMS Bellerophon e di porsi sotto la protezione della legge inglese; la vana attesa, a Plymouth, di una risposta alla richiesta di asilo e lo sconforto del responso: il ‘generale Buonaparte’, dovrà essere deportato come semplice prigioniero di guerra a Sant’Elena. E poi, a bordo dell’HMS Nothumberland: 93 giorni di navigazione, fino al 15 ottobre 1815, in un ambiente umiliante e soffocante, anticipazione del declino dei piovosi tramonti a Longwood House, sull’isola delle nebbie. Proprio durante questa lenta navigazione Napoleone inizierà a dettare le sue memorie.
